
Colours

somma 2
 somma 3
somma 3

colori caldi e freddi






![]() primari
primari
![]()
![]()
![]()
![]()
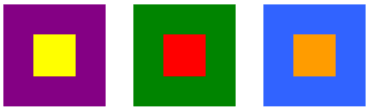


Accostamenti: introduzione alla teoria dei colori
Il colore non è una caratteristica assoluta della materia, ma relativa alla qualità dell’illuminazione sotto la quale lo percepiamo. In genere noi chiamiamo “luce” l’illuminazione proveniente dal sole o da una lampadina, ma in realtà queste non sono altro che una porzione dello spettro elettromagnetico che la razza umana può percepire attraverso gli occhi.
Se qualche giorno ci svegliamo un po’
prima dell’alba e ci mettiamo col naso incollato alla finestra ed una
tazza di tè bollente in mano, potremo vedere come il mondo fuori sia
nero. Nera l’erba del prato, nere le rose appena sbocciate, neri i
cespugli di lavanda. Tutti i colori spariti, come rubati dallo Spirito
della Notte di Maurice Maeterlinck. E’ solo poco più di una metafora
poetica, sappiamo con certezza che al mattino, quando brillerà il sole,
la lavanda tornerà ad essere grigio argento e l’erba verde, ma senza il
sole, una lampada o un fiammifero che le illumini, i loro colori cessano
di esistere.
Mano a mano che sorge il sole i colori
riemergono, dapprima i rossi e poi via via tutti gli altri, passando
attraverso mille, magnifiche, sfumature di grigio.
Tutti sappiamo come il colore delle
pagine di un libro cambi se leggiamo alla luce delle comuni lampadine al
tungsteno o a quella delle lampade al neon. Più gialla la prima, più
bianca e fredda la seconda. Quante volte, disegnando, abbiamo deciso di
rimandare al giorno successivo per non dover continuare con la luce
artificiale che “falsa i colori”?
Se avete visto “The Abyss” ricorderete
la scena in cui Ed Harris doveva tagliare il filo d’innesco di una
bomba, ma aveva a disposizione solo una torcia da sommozzatore che
emanava una luce giallastra, sicché il filo bianco e quello giallo erano
identici l’uno all’altro.
Quindi, se cambia il colore della luce,
cambia anche il colore dell’oggetto che ne è illuminato; è un’esperienza
empirica che ci capita spesso di fare.
Tutti sappiamo anche che la luce bianca
(la porzione di spettro elettromagnetico che va dall’infrarosso
all’ultravioletto) è composta da molti altri colori; Newton ne individuò
sette con il celeberrimo esperimento del prisma, ma in realtà sono
infiniti, poiché in fisica i colori non sono altro che determinate
frequenze dello spettro visibile... sembrerebbe quasi di offendere i
malva, i cremisi, i turchesi, gli ocra, ma invece è un mondo molto
affascinante quello dei colori, proprio per questa loro duplice veste di
precisi ed algidi elementi della scienza e caldo e morbido mondo delle
sensazioni, del piacere e dei ricordi.
cerchio cromatico
I colori primari per l’artista sono
cinque: il magenta, il ciano, il giallo primario, il bianco ed il nero.
Con questi cinque colori è possibile ottenere qualunque sfumatura
cromatica. Molto spesso si fa una gran confusione su quello che è un
colore primario, un secondario e un complementare. Se prendete un testo
di fotografia o una dispensa di scuola di pittura potreste trovare che
come colori primari vengono indicati il rosso, il verde ed il
blu-violetto. E’ vero, questi sono i colori primari della luce, in
fisica. Se prendiamo tre distinti fasci di luce, uno rosso, uno verde ed
uno blu-violetto, e li facciamo convergere al centro, troveremo come la
somma di tutti e tre dà bianco, mentre la somma tra il rosso e il verde
dà il giallo, tra il verde e il blu-violetto dà il ciano, tra il
blu-violetto e il rosso il magenta.
Rosso, verde e blu-violetto sono quindi
i colori primari della sintesi che viene chiamata “additiva”, poiché la
somma dei tre colori dà il bianco, mentre magenta, giallo e ciano ne
sono i colori secondari.
Viceversa se prendiamo tre distinti
fasci di luce, uno magenta, uno ciano ed uno giallo, la somma dei tre dà
il nero, mentre sommati a due a due danno rosso, verde e blu-violetto (magenta
+ ciano=blu-violetto; ciano+giallo=verde; giallo+magenta=rosso).
Magenta, ciano e giallo diventano quindi i colori primari della sintesi
“sottrattiva”,così chiamata perché la somma dei tre dà il nero.
Vedete perciò che dire “colore primario”
non è modo univoco di far capire di che tipo di colore primario stiamo
parlando. Ad esempio bianco e nero sono colori primari per l’artista,
poiché non possono essere ottenuti attraverso nessuna combinazione degli
altri colori (magenta, giallo e ciano), ma in fisica non esistono perché
il bianco è la somma di tutti i colori, mentre il nero è l’assenza di
luce e quindi di colore.
Limitandoci alla sintesi cromatica “sottrattiva”,
che è la sola utile ai nostri scopi, possiamo individuare dei colori
secondari ottenuti attraverso una adeguata miscelazione dei tre primari.
Come vedete dallo schema qui
raffigurato, dalla somma di magenta e giallo si ottiene il rosso
vermiglione, dalla somma di giallo e ciano il verde pisello, e dalla
somma di ciano e magenta il violetto. In base alle quantità di
ognuno dei colori primari avremo dei colori più o meno vicini al
primario. Così un verde a cui sia aggiunto meno ciano darà il colore dei
limoni ancora acerbi, o dei teneri germogli dei gelsi. Un rosso a cui
sia aggiunto molto magenta darà il colore della rosa “Lady Mitchell”, o
della “Elfhorn”. Se al contrario aggiungiamo più giallo avremo il colore
della “Pat Austin”. E così via.
Le sfumature che vanno dal magenta al
giallo vengono chiamate “calde”, mentre le tinte tra il verde e il
violetto vengono chiamate “fredde”, sebbene sia importante sottolineare
come anche un azzurro, che generalmente è sempre considerato “freddo”,
possa esserlo più o meno a seconda della percentuale di magenta che vi
è mescolata, così anche un giallo, colore caldo per eccellenza, può
tendere leggermente al verde od al grigio e risultare più freddo della
controparte cui sia aggiunto un po’ di magenta.
I colori che si trovano agli opposti del
cerchio vengono chiamati “complementari” l’uno dell’altro e non
contengono alcun pigmento in comune. I colori complementari accostati
danno una impressione ottica quasi sempre considerata molto gradevole,
inoltre danno un’idea di completezza poiché contengono tutti e tre i
pigmenti primari, seppur separati.
Accostando un colore al suo
complementare otterremo il risultato di rafforzarlo, di esaltarlo. Ad
esempio un arancio apparirà più vivace, più squillante, più “giallo”, se
accostato ad un blu cobalto o ad un oltremare, ma certamente più pallido
e meno carico se accostato ad un rosso pomodoro. E’ bene tenere presente
questi contrasti in giardino. Se vorremo esaltare il colore di una
macchia di narcisi, non certo vi pianteremo vicino dei tulipani rossi!
Purtroppo è un errore piuttosto comune pensare che per evidenziare un
colore bisogni accompagnarlo con una tinta della stessa tonalità ma più
forte. Invece è l’esatto contrario.
Pensate agli esempi estremi: bianco e
nero. Nero su nero o bianco su bianco hanno valore di contrasto nullo,
ma nero su bianco o bianco su nero hanno il massimo valore di contrasto.
Usare il colore in giardino è una
faccenda tutt’altro che semplice e richiede pazienza ed esperienza, non
solo buon gusto e un po’ di conoscenza della teoria dei colori. Questo
accade perché i fiori hanno delle tinte impure, contenenti percentuali
variabili di bianco e nero, spesso sono variegati o sfumati, oppure
cambiano colore a seconda dell’esposizione e dell’epoca di fioritura.
Tuttavia conoscere la teoria dei colori
è un buon aiuto per partire col piede giusto e può essere un valido
supporto nel momento in cui ci troveremo in panne senza sapere bene cosa
fare.
Poniamo ad esempio di avere un muro di
mattoni rossi, benché qui in Italia siano piuttosto difficili da
trovare. Se vogliamo addossarvi un rampicante è assolutamente da evitare
qualsiasi cosa che sia rossa o arancione, poiché godrebbe di poco
contrasto. Invece un fiore bianco o rosa pallido spiccherebbe assai
maggiormente. Così un geranio color fucsia vicino ad un Coleus a foglia
dorata, o una Iresine a foglia porpora vicino ad una lavanda color
grigio azzurro.
Potrete utilizzare i contrasti “al
contrario” se invece volete smorzare una tinta. Se avete una verbena il
cui violetto non vi piace più come quando l’avete comprata, potrete
attutirne la tinta accostandovi un Senecio cineraria. Sarà una tonalità
fredda e neutra vicino ad una sempre appartenente alla fascia dei colori
freddi, ma con una non indifferente percentuale di magenta (le verbene
si sa che non sono mai abbastanza azzurre), quindi più calda; con il
risultato che questi colori tenderanno ad incontrarsi al centro e
fondersi. Se invece vi accostiamo del Coreopsis non ci sarà più un
“centro” ottico verso cui dirigersi, ed ognuno dei due colori tenderà ad
andare per conto suo.
Tutti abbiamo presente il famoso
giardino bianco di Sissinghurst Castle, in cui Vita Sackville-West mise
fiori prevalentemente bianchi. Prevalentemente, ma non esclusivamente.
Come abbiamo già detto, il bianco sul bianco non ha alcun valore di
contrasto, per cui ella, con molta sapienza ed abilità, inserì dei fiori
dalle tinte leggermente rosate proprio per far risaltare il bianco.
In fondo non dobbiamo pensare al
giardino a qualcosa di molto differente dalla nostra casa. Un divano
color ruggine ha bisogno di un cuscino turchese per essere esaltato,
così come una tappezzeria verde giallastro di un accento di carmino
chiaro.
|
VISIONE DEI
COLORI
L'occhio umano è sensibile alle onde
elettromagnetiche di lunghezza d'onda fra 400 e 700 nm (Fig. 27), che quindi
compongono la "luce" visibile. In questo ambito, lunghezze d'onda diverse
vengono interpretate come colori diversi, con una lenta variazione dal blu, al
verde, al rosso, man mano che la lunghezza d'onda aumenta. Le persone che hanno
una visione normale dei colori sono in grado di riconoscere miscele di
radiazioni luminose di qualsiasi lunghezza d'onda, combinando in tre proporzioni
opportune tre colori primari: il blu, il verde ed il rosso. Questa proprietà
della visione dei colori, detta tricromia, dipende dalla presenza nella retina
di tre tipi distinti di coni, ognuno dei quali possiede un pigmento visivo
diverso. I tre pigmenti visivi si differenziano per la loro parte proteica e non
per il cromoforo, che è sempre il retinale. La diversa conformazione proteica (cfr.
Fig. 20D)
"filtra" la luce differentemente, facendo sì che solo certe lunghezze d'onda e
non altre possano essere assorbite dal cromoforo, innestando così la catena
della fototrasduzione.
Ciascuno dei tre pigmenti ha uno spettro di assorbimento particolare, anche se
ampiamente sovrapposto a quello degli altri tipi. Un tipo di pigmento è
particolarmente sensibile alle lunghezze d'onda più corte dello spettro visibile
e contribuisce notevolmente alla percezione del blu (viene anche chiamato
pigmento C, per onde corte, o B per blu). Un altro tipo di pigmento è
particolarmente sensibile alle lunghezze d'onda medie e contribuisce
notevolmente alla percezione del verde (viene detto M o V).
 |
| Fig. 28 |
STEREOPSI
Uno dei principali compiti del sistema
visivo, essenziali per l'interazione dell'individuo con l'ambiente, è quello di
conferire alle immagini visive bidimensionali una valenza tridimensionale. Si
ritiene che il passaggio dalla visione a due dimensioni a quella tridimensionale
si basi su due tipi di elementi di valutazione: elementi stereoscopici basati
sulla binocularità ed elementi monoculari relativi alla profondità di campo.
La visione stereoscopica si basa sul confronto delle immagini retiniche dei due
occhi, ed è efficace fino ad una distanza di circa 30 metri, oltre la quale le
immagini retiniche dei due occhi sono praticamente identiche. Quando si fissa un
oggetto, l'immagine del punto di fissazione va a cadere, in ciascun occhio,
sulla fovea, grazie ai movimenti di vergenza. Siccome, però, gli occhi distano
circa 6 cm l'uno dall'altro, ogni oggetto che sia più vicino o più lontano
rispetto al punto di fissazione proietta la propria immagine ad una certa
distanza dalla fovea. In particolare, gli oggetti più vicini proiettano la
propria immagine su punti della retina più distanti in senso orizzontale; gli
oggetti più lontani la proiettano su punti della retina più vicini (Fig.
28B). In altri termini, tanto più un oggetto è vicino all'osservatore,
rispetto ad un punto di fissazione più lontano, tanto più le sue immagini si
formeranno, su ogni occhio, esternamente rispetto alla fovea. La distanza fra
immagini del punto fissato ed immagini dell'altro punto prende il nome di
disparità retinica. Questo fenomeno è apprezzabile anche soggettivamente. Se si
fissa un oggetto posto ad una certa distanza (1-2 metri, ad esempio), tutte le
immagini degli oggetti più vicini e più lontani rispetto a quello fissato
appaiono sdoppiate. Il sistema visivo è in grado di calcolare tale disparità e
di assegnare, quindi, un senso di maggiore o minore profondità agli oggetti
dello spazio visivo.
La visione stereoscopica